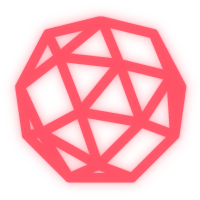Scuole e Spazio: Viaggio tra Educazione, Creatività e Startup Intergenerazionali
Scuole e Spazio: Viaggio tra Educazione, Creatività e Startup Intergenerazionali
Sintesi Iniziale
Lo spazio sta diventando un’aula senza confini, dove studenti di tutte le età collaborano con scienziati, artisti e imprenditori per spingersi “oltre” i tradizionali percorsi educativi. In tutta Italia nascono progetti che portano satelliti in miniatura costruiti da ragazzi in orbita, laboratori che fondono scienza, arte e tecnologia in esperienze immersive, e persino startup spaziali fondate da giovanissimi con il supporto di mentori esperti. Queste iniziative hanno obiettivi ambiziosi: stimolare vocazioni STEM attraverso sfide reali, sviluppare competenze trasversali (dalla progettazione ingegneristica alla creatività artistica), e favorire l’imprenditorialità giovanile in un settore – la space economy – in rapida espansione.
Perché collegare scuole e spazio? I risultati finora mostrano un impatto concreto: studenti delle elementari imparano concetti di astronomia giocando a fare gli astronauti, adolescenti delle superiori progettano e lanciano veri esperimenti in orbita, team intergenerazionali trasformano idee scolastiche in startup innovative. In questo report approfondiremo casi di successo italiani – con uno sguardo anche a esempi globali d’eccellenza – evidenziando obiettivi educativi, partner coinvolti, tecnologie utilizzate e risultati ottenuti. Scopriremo, ad esempio, come un gruppo di liceali italiani ha contribuito a una missione CubeSat dell’ESA, come un laboratorio creativo interplanetario può unire poesia e robotica, e come tre neolaureate hanno fondato una startup per proteggere i satelliti dai detriti spaziali.
Invito alla lettura: Attraverso sezioni tematiche e case study, vedremo come queste iniziative stanno democratizzando l’accesso allo spazio (anche per i più piccoli), creando una nuova alleanza tra scuola e industria spaziale e preparando la strada a progetti visionari come Galaxy Bakery. Pronti a esplorare queste frontiere educative? Seguiteci in questo viaggio tra stelle e banchi di scuola!
Missioni studentesche e satelliti educativi
(Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino)
L’idea di costruire e lanciare satelliti a scopo educativo è diventata realtà in varie scuole e università italiane, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza pratica di ingegneria aerospaziale ( Gli studenti vanno in orbita con l’Agenzia aerospaziale – Cronaca) ( Gli studenti vanno in orbita con l’Agenzia aerospaziale – Cronaca). Queste “missioni studentesche” permettono di imparare facendo: i ragazzi, guidati da docenti e mentori delle agenzie spaziali, progettano componenti reali, li integrano su mini-satelliti e ne seguono il lancio e l’analisi dei dati. Partner chiave in Italia sono l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed ESA, insieme a università (Politecnico di Torino, Sapienza di Roma, ecc.) e aziende hi-tech. Iniziative come il progetto EduSAT – un microsatellite educativo finanziato da ASI – hanno coinvolto una rete di istituti tecnici e licei: gli studenti, coordinati dall’Istituto Majorana di Seriate (Bergamo), hanno progettato esperimenti (es. un sensore solare ideato da studenti) poi lanciati a bordo del satellite ( Gli studenti vanno in orbita con l’Agenzia aerospaziale – Cronaca) (EDUSAT). In questo programma pluriennale, docenti e studenti diventano protagonisti di una vera missione spaziale, approfondendo meccanica orbitale, ambiente spaziale e operazioni di terra, con software dedicati per simulare orbite (Celestia, Orbitron) ( Gli studenti vanno in orbita con l’Agenzia aerospaziale – Cronaca). L’obiettivo didattico dichiarato era “avvicinare gli studenti alle professioni aerospaziali” ( Gli studenti vanno in orbita con l’Agenzia aerospaziale – Cronaca), risultato centrato: molti partecipanti hanno proseguito in carriere scientifiche, forti dell’esperienza diretta acquisita.
Al livello universitario, i team studenteschi italiani competono anche in programmi internazionali. Ad esempio, il Team CubeSat del Politecnico di Torino – 39 studenti e dottorandi – è stato selezionato dall’ESA per il programma Fly Your Satellite! – Design Booster, concepito per supportare le migliori università europee nella progettazione di missioni innovative (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino) (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino). Con il progetto ELECTRA, questo team sta sviluppando un CubeSat 3U (10x10x30 cm) con un micro-propulsore a stato solido e un sistema avanzato di navigazione GNSS, puntando anche a sperimentare il rientro controllato secondo l’approccio “Zero Debris” (nessun detrito spaziale lasciato in orbita) (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino) (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino). Gli obiettivi sono contemporaneamente educativi (formare futuri esperti, avvicinare il mondo accademico all’industria), scientifici (mappare la ionosfera tramite il satellite) e tecnologici (testare propulsori innovativi) (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino) (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino). Partner come i laboratori di ricerca STARLab e NavSAS del Politecnico e la comunità YoungNav affiancano gli studenti, dimostrando il valore di team intergenerazionali dove professori, dottorandi e undergrad lavorano fianco a fianco (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino) (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino). Il risultato atteso non è solo un satellite funzionante, ma anche metodologie replicabili per colmare il gap tra università e lavoro, facilitando l’accesso dei giovani al settore spaziale (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino).
Le scuole superiori non stanno a guardare: in Piemonte, ad esempio, il Liceo Scientifico di Gattinara ha avviato un progetto per progettare un CubeSat per la mappatura dei detriti spaziali, nell’ambito del concorso “ZR Sat” legato a Zero Robotics (Politecnico di Torino) (Liceo Gattinara al lavoro per progettare un satellite). In parallelo, lo stesso team studentesco “FerMer Robotics” ha sviluppato un rover autonomo per usi di protezione civile, dimostrando come coding e robotica possano applicarsi sia allo spazio che alla società (Liceo Gattinara al lavoro per progettare un satellite). Da notare che questa squadra è formata da sole ragazze, a riprova di come lo spazio possa attirare talenti diversificati e promuovere le STEM al femminile (Liceo Gattinara al lavoro per progettare un satellite). Anche qui, i partner sono cruciali: il Politecnico fornisce il contesto competitivo e formativo, mentre il Ministero dell’Istruzione sostiene attraverso programmi come il Premio Scuola Digitale (Liceo Gattinara al lavoro per progettare un satellite).
Oltre alla costruzione di satelliti veri e propri, molte scuole partecipano a competizioni didattiche internazionali legate allo spazio. L’ASI e l’ESA tramite il programma ESERO Italia propongono ogni anno sfide come:
-
CanSat (costruisci un mini-satellite grande come una lattina) – dove team di studenti 14-19 anni progettano una “sonda” da lanciare con un razzo a bassa quota (ASI | Agenzia Spaziale Italiana). In queste gare, i ragazzi curano payload scientifici (ad esempio misurare dati ambientali durante la discesa) e competono a livello nazionale ed europeo, sviluppando competenze di elettronica e problem solving.
-
Astro Pi (coding su Raspberry Pi a bordo della ISS) – progetto in cui studenti 9-19 anni programmano esperimenti da eseguire sui mini-computer AstroPi installati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ASI | Agenzia Spaziale Italiana). Questa attività unisce informatica e spazio: i giovani imparano a codificare in Python per raccogliere dati reali in microgravità (ad esempio monitorare parametri ambientali della ISS o scattare foto della Terra), con il coinvolgimento diretto degli astronauti che eseguono i loro programmi.
-
Mission X (Allenati come un astronauta) – una sfida internazionale per scuole medie che combina scienze dello spazio ed educazione fisica: gli studenti seguono un “training” ispirato agli astronauti, imparando concetti di nutrizione e esercizio fisico, e accumulano punti a livello globale (ASI | Agenzia Spaziale Italiana).
-
Moon Camp (progetta una base lunare) – rivolta anche a bambini delle elementari: in team i partecipanti disegnano con strumenti 3D il loro avamposto sul nostro satellite, integrando nozioni di scienza planetaria, design e abitabilità (ASI | Agenzia Spaziale Italiana).
Queste attività, spesso svolte in orario extracurricolare o come progetti PCTO, vedono la collaborazione di agenzie spaziali (ESA/ASI), musei della scienza e planetari locali, aziende (che talvolta forniscono kit o software), e sono supportate da piattaforme online che mettono in rete docenti e studenti di tutta Europa (A scuola con lo spazio: al via la nuova edizione del progetto ESERO …). I risultati sono tangibili: aumento della motivazione verso le materie STEM, sviluppo di competenze tecniche (dall’elettronica alla programmazione) ma anche soft skill come il lavoro in squadra e il project management. Molti studenti riferiscono di aver scoperto grazie a questi progetti la passione per l’ingegneria o l’astrofisica, orientando poi di conseguenza i loro studi universitari.
Dal punto di vista globale, un caso emblematico importabile anche in Italia è la competizione Cubes in Space, patrocinata dalla NASA: ragazzi dagli 11 ai 18 anni in tutto il mondo progettano micro-esperimenti da inserire in un cubo di 10 cm³, i migliori dei quali vengono lanciati su razzi suborbitali o palloni ad alta quota (Indian teen builds world’s ‘lightest satellite’ | World Economic Forum). Nel 2017 un team di studenti indiani guidati dal 18enne Rifath Shaarook ha stabilito un record con KalamSat, il più leggero satellite mai lanciato (appena 64 grammi di peso!) (Indian teen builds world’s ‘lightest satellite’ | World Economic Forum). Sostenuti dall’organizzazione educativa Space Kidz India, questi ragazzi hanno progettato e stampato in 3D da zero un dispositivo grande quanto una pallina da tennis, dotato di sensori per misurare temperatura, pressione e radiazioni in volo (Indian teen builds world’s ‘lightest satellite’ | World Economic Forum) (Indian teen builds world’s ‘lightest satellite’ | World Economic Forum). Il loro CubeSat, battezzato in onore dello scienziato e ex-Presidente indiano A. P. J. Abdul Kalam, è volato sul razzo NASA Terrier-Improved Orion, dimostrando con successo le prestazioni di materiali in fibra di carbonio stampati in 3D nello spazio (Indian teen builds world’s ‘lightest satellite’ | World Economic Forum). Progetti come questo mostrano il potenziale delle sfide internazionali nell’accendere l’entusiasmo scientifico: con poca spesa e tanta ingegnosità, anche giovani di scuole superiori possono contribuire ad avanzamenti tecnologici reali, ottenendo riconoscimenti globali e ispirando coetanei (KalamSat è stato spesso citato come esempio nelle scuole di diversi Paesi).
Un altro esempio globale di successo è Zero Robotics, la gara di programmazione di robotica in microgravità: nata al MIT con il supporto di NASA ed ESA, ha coinvolto anche molte scuole italiane. In questo torneo, squadre di liceali scrivono codice per controllare satelliti robotici all’interno della Stazione Spaziale Internazionale, affrontando sfide come “catturare” virtualmente detriti o gestire risorse limitate. Le finali si svolgono dal vivo con gli astronauti sulla ISS che eseguono i codici degli studenti in diretta. Diversi licei italiani (da Torino a Livorno) hanno brillato in questa competizione, vincendo edizioni passate e mostrando un alto livello di preparazione (Zero Robotics High School 2018 Champions! – MIT) (Zero Robotics High School 2018 Champions! – MIT). L’impatto educativo è notevole: i partecipanti apprendono principi di matematica, fisica e informatica applicandoli a un problema concreto nello spazio, e vivono l’emozione di vedere il proprio software “giocare” in orbita. Inoltre, essendo una competizione internazionale, migliorano l’inglese tecnico e lo scambio culturale, formando alleanze con team di altri Paesi.
In sintesi, le missioni e competizioni studentesche legate allo spazio rappresentano un nuovo paradigma educativo: learning by doing in senso letterale, con i giovani che non solo studiano lo spazio sui libri, ma fanno spazio in prima persona. Grazie al supporto di agenzie, università e aziende, la scuola si apre a laboratori diffusi che possono trovarsi in un’aula come in una base di lancio. I risultati attesi (e in parte già raggiunti) includono un maggiore numero di studenti che intraprendono studi scientifici, una più stretta relazione tra scuole e mondo della ricerca, e una generazione più consapevole dell’importanza dello spazio per la società (dalle telecomunicazioni all’osservazione della Terra). E per alcuni, queste esperienze sono state il trampolino di lancio di vere carriere e startup – come vedremo nelle sezioni successive.
Laboratori interdisciplinari: dove Scienza, Arte e Tecnologia si incontrano
(The Moon Gallery: the first museum in space) La collezione d’arte “Moon Gallery” esposta nella Cupola della Stazione Spaziale Internazionale: elementi artistici viaggiano nello spazio per ispirare un futuro interplanetario culturale (The Moon Gallery: the first museum in space).
Non solo ingegneria: lo spazio può essere un crocevia creativo, capace di unire discipline diverse come arte, design, letteratura e tecnologia in contesti educativi unici. In Italia stanno nascendo laboratori interdisciplinari che fondono conoscenze scientifiche con espressioni artistiche, offrendo agli studenti percorsi formativi completi e inclusivi (le cosiddette metodologie STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). L’obiettivo dichiarato di queste iniziative è sviluppare sia il pensiero analitico che quello immaginativo, mostrando che per esplorare lo spazio servono tanto competenze tecniche quanto visioni creative e umanistiche.
Un caso notevole è il progetto “Educazione all’immagine a 360°” della Fondazione Golinelli di Bologna, che ha coinvolto studenti di scuole secondarie nella creazione di un gemello digitale di una mostra dal titolo emblematico: “Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi”. In questa mostra – frutto della collaborazione tra Fondazione Golinelli, l’Università di Bologna (Sistema Museale d’Ateneo) ed ESA – oggetti scientifici e opere d’arte convivevano fianco a fianco (Fondazione Golinelli). I ragazzi, durante percorsi di PCTO, hanno lavorato con esperti di museologia, programmatori e artisti per scannerizzare e riprodurre in realtà virtuale i reperti e le installazioni, creando un ambiente immersivo fruibile con visori Oculus (Fondazione Golinelli) (Fondazione Golinelli). Il risultato è una mostra virtuale interattiva, dove è possibile “camminare” tra quadri rinascimentali, installazioni artistiche moderne e modelli di colonie marziane futuribili, il tutto accompagnato da narrazioni poetiche e scientifiche. Questo laboratorio ha permesso agli studenti di sviluppare competenze tecniche (modellazione 3D, VR) ma anche di apprezzare la contaminazione tra arte e scienza: ad esempio, hanno visto come un dipinto di fine ‘500 può dialogare con immagini fornite dall’Agenzia Spaziale Europea, inseriti in un’unica storia che collega il sapere umanistico alle esplorazioni spaziali (Fondazione Golinelli). Iniziative così mostrano ai giovani che la cultura scientifica e quella artistica non sono mondi separati, ma possono arricchirsi a vicenda – un messaggio fondamentale per formare menti flessibili e creative.
Un altro esempio è dato dai laboratori condotti in musei scientifici e festival tecnologici. Durante il Festival dell’Aerospazio 2023, la Città della Scienza di Napoli ha presentato un’attività laboratoriale per studenti delle medie dedicata alla capsula Orion (veicolo NASA per missioni lunari), combinando aspetti ingegneristici con storytelling creativo: i ragazzi hanno immaginato e disegnato come potrebbe essere vivere all’interno della capsula durante un viaggio verso la Luna, mescolando nozioni di spazio con esercizi di fantasia. Allo stesso modo, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano offre da anni workshop come “AstroDesign”, in cui studenti e famiglie costruiscono insieme modellini di habitat spaziali o rover marziani utilizzando materiali riciclati e tecniche artistiche, per poi testarli in sandbox che simulano il suolo extraterrestre. Queste attività, spesso svolte in partnership con aziende (es. Leonardo-Finmeccanica fornisce mockup di satelliti) o con l’ASI (che porta nelle mostre pezzi originali come tute spaziali o frammenti di satelliti), hanno duplice scopo: da un lato insegnare concetti scientifici (astronomia, robotica) in modo esperienziale, dall’altro stimolare creatività e sensibilità estetica anche in contesti STEM.
A livello globale, uno dei progetti più affascinanti è la Moon Gallery, un’iniziativa artistica internazionale che aspira a creare la prima galleria d’arte sulla Luna. Curata da un collettivo di artisti e scienziati (nell’ambito del programma ArtMoonMars di ILEWG), la Moon Gallery raccoglie decine di piccole opere d’arte – ciascuna grande pochi centimetri – pensate per essere inviate nello spazio come “semi di cultura” per future società interplanetarie ([
ArtMoonMars · EuroMoonMars
ArtMoonMars · EuroMoonMars
](https://euromoonmars.space/Artmoonmars/main/#:~:text=the%20global%20space%20exploration%20and,a%20series%20of%20open%20calls)). Dopo varie esposizioni sulla Terra e addirittura un’installazione sperimentale nella Stazione Spaziale Internazionale (dove un quadro di 10×10 cm con 64 micro-artefatti è stato esposto alla vista degli astronauti) (The Moon Gallery: the first museum in space), l’obiettivo è lanciare 100 artefatti artistici sulla superficie lunare entro pochi anni. La domanda guida del progetto è provocatoria: “Quali idee e valori culturali vogliamo portare con noi nello spazio?” (The Moon Gallery: the first museum in space). Attraverso workshop, classi di arte-scienza e open call, Moon Gallery ha coinvolto studenti universitari di design, ingegneri, artisti e persino bambini, invitandoli a proporre oggetti simbolici da inviare sulla Luna (The Moon Gallery: the first museum in space) ([
ArtMoonMars · EuroMoonMars
](https://euromoonmars.space/Artmoonmars/main/#:~:text=culture%2C%20rethink%20our%20values%20for,better%20living%20on%20Earth%20planet)). Si va da sculture minuscole realizzate con materiali innovativi, a semi di piante avvolti in opere concettuali, ognuna rappresentante un aspetto dell’esperienza umana (sogni, memorie, speranze) che riteniamo fondamentale condividere oltre la Terra. Il valore educativo è duplice: si insegna la tecnologia spaziale attraverso l’arte (come proteggere un manufatto dalle radiazioni cosmiche? come miniaturizzare un messaggio culturale?), e si utilizza lo spazio come sfondo per discussioni filosofiche ed etiche (ad esempio nelle classi: “cosa mettereste voi in una capsula del tempo diretta sulla Luna?”). Il messaggio della Moon Gallery – portare arte e creatività nello spazio prima che armi e interessi la colonizzino (The Moon Gallery: the first museum in space) – è in sé una potente lezione di cittadinanza cosmica che sta ispirando studenti e docenti in vari Paesi. In Italia, alcuni istituti d’arte e licei hanno seguito il progetto, inserendolo nei propri programmi di educazione civica e progettazione, e non è difficile immaginare di ospitare in futuro una “mini Moon Gallery” itinerante nelle scuole, per stimolare anche i più giovani a pensare allo spazio in termini culturali e non solo scientifici.
Da menzionare è anche l’iniziativa ArtMoonMars, collegata alla precedente: è una piattaforma che organizza incontri e laboratori proprio per connettere arte, Luna, Marte e oltre. Durante queste sessioni – spesso in collaborazione con analoghi astronautici (simulazioni di missioni lunari in ambienti terrestri) – artisti e studenti creano performance, musica e opere visive ispirate all’esplorazione spaziale ([
ArtMoonMars · EuroMoonMars
ArtMoonMars · EuroMoonMars
](https://euromoonmars.space/Artmoonmars/main/#:~:text=Moon%20Gallery%20Project)). Ad esempio, nell’habitat di simulazione HI-SEAS alle Hawaii, durante una missione analogica è stata allestita una galleria d’arte temporanea per gli “astronauti” partecipanti, dimostrando come anche in condizioni estreme l’espressione artistica abbia un ruolo nel benessere psicologico e nell’innovazione (un concetto che NASA stessa sta esplorando integrando arte-terapia e design nei programmi per astronauti).
In sintesi, i laboratori interdisciplinari spazio-arte-tecnologia perseguono obiettivi educativi ampi: non solo avvicinare nuovi pubblici alle materie scientifiche, ma anche coltivare pensiero critico, immaginazione e sensibilità verso temi globali (come l’uso etico dello spazio, la sostenibilità ambientale, il patrimonio culturale dell’umanità da preservare). I partner coinvolti variano da agenzie spaziali che offrono contenuti (ESA ha fornito immagini e materiali per la mostra Golinelli (Fondazione Golinelli)), a fondazioni culturali, musei, università (che portano competenze storiche e artistiche), fino a enti locali e sponsor privati che credono nell’educazione STEAM. I risultati sono spesso esperienze intangibili ma preziose: studenti più motivati, capaci di collegare Petrarca ai pianeti o Dante alle stelle, progetti scolastici che diventano eventi pubblici (mostre, performance), una maggiore inclusione di studenti con diversi talenti (non solo i “bravi in matematica”, ma anche creativi, musicisti, scrittori trovano spazio in questi progetti). Questo approccio interdisciplinare forma individui completi, pronti in futuro a risolvere problemi complessi con approcci innovativi – qualità essenziali anche nel mondo del lavoro moderno, spazio incluso. E chissà, alcuni magari diventeranno i designer delle prime case su Marte o i curatori museali della Luna, professioni che oggi sembrano fantascienza ma che domani potrebbero esistere grazie a questa semina creativa.
Giovani startup spaziali e team intergenerazionali
(Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia) Giovani ingegneri italiani presentano un prototipo di razzo ecologico durante un evento internazionale (IAC 2024), esempio di come ricerca accademica e spirito imprenditoriale possano incontrarsi (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia) (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia).
L’ecosistema spaziale non è più dominio esclusivo delle grandi agenzie governative: la New Space Economy vede una fioritura di startup e PMI innovative. In questo contesto, l’Italia sta assistendo alla nascita di imprese fondate da giovani under-30, spesso appena usciti dall’università o addirittura ancora studenti, che portano sul mercato idee sviluppate in ambito accademico. Molte di queste nuove aziende hanno team intergenerazionali, dove l’entusiasmo e le competenze digitali dei più giovani si combinano con l’esperienza di mentori, professori o professionisti senior. Queste startup hanno obiettivi che non sono solo commerciali ma anche educativi e sociali: diffondere la cultura spaziale, creare opportunità per altri giovani, risolvere problemi globali (ad esempio i detriti spaziali o il monitoraggio ambientale) e collegare l’Italia alle reti internazionali dell’innovazione.
Un esempio di startup “made in Italy” fondata da giovani è Evolunar. Nata come progetto universitario nel 2020 e diventata azienda nel 2022, Evolunar è guidata da Giuseppe Bortolato (classe 1996) e ha come co-ideatore l’astronauta italiano Roberto Vittori (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia). Si tratta quindi di un caso lampante di team intergenerazionale: un astronauta veterano ha ispirato e supportato un giovane ingegnere perché sviluppasse un’idea ambiziosa. L’azienda progetta quelli che definisce “droni lunari”, ovvero piccoli veicoli volanti capaci di esplorare le grotte laviche della Luna – possibili rifugi per future basi lunari (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia). La tecnologia di Evolunar punta a risolvere problemi pratici dell’esplorazione: i droni, senza eliche ma con micro-propulsori, potrebbero perlustrare dall’interno caverne e pozzi lunari (inaccessibili ai rover) per valutare stabilità, radiazioni e condizioni ambientali (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia). È una soluzione innovativa sia per l’exploration sia per la logistica lunare (immaginiamo in futuro consegne di strumenti attraverso questi droni) (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia). Gli obiettivi qui sono chiaramente tecnologici (sviluppare un nuovo mezzo di esplorazione spaziale), ma anche formativi: Evolunar è nata in collaborazione con l’Università di Padova e mira a coinvolgere studenti in stage e tesi, offrendo un ponte tra ricerca accademica e impresa. Partner come l’Agenzia Spaziale Europea hanno mostrato interesse (il progetto ha attirato l’attenzione a congressi internazionali come lo IAC), e la presenza di Vittori assicura collegamenti con enti come l’Aeronautica Militare e aziende del settore. Risultati attesi: se i prototipi di droni lunari supereranno i test (magari in ambienti analoghi terrestri), Evolunar potrebbe partecipare a missioni lunari internazionali, mettendo l’Italia all’avanguardia in questo niche. Nel frattempo, già il percorso di creazione dell’azienda ha avuto un impatto: dimostrare che un giovane di 25 anni può guidare un progetto spaziale complesso funge da ispirazione per molti studenti (come riportato da Wired, si sta “democratizzando il cosmo” e offrendo “opportunità enormi per chi saprà coglierle” (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia) (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia)).
Un altro caso notevole è Ecosmic, fondata da tre ragazze poco più che ventenni con laurea in ingegneria aerospaziale (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e TU Delft). Benedetta Cattani, Imane Marouf e Gaia Roncalli – 25-27 anni – si sono conosciute durante uno stage all’ESA nei Paesi Bassi e lì hanno deciso di lanciare la loro startup (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it) (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it). Ecosmic sviluppa un software avanzato per la valutazione del rischio di collisione tra satelliti e detriti spaziali, un problema sempre più critico dato l’affollamento delle orbite (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it) (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it). L’originalità del prodotto sta nell’algoritmo di calcolo ad altissima accuratezza della probabilità di impatto, utile sia per operatori satellitari commerciali che per agenzie spaziali (che vogliono evitare incidenti in orbita). Dopo un periodo all’estero, le fondatrici hanno riportato Ecosmic in Italia, scegliendo come sede Torino – cuore del distretto aerospaziale nazionale – e inserendosi nell’incubatore ESA BIC locale (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it). Questo garantisce partnership con aziende del territorio e mentoring da parte di esperti del Politecnico di Torino. Obiettivi educativi/imprenditoriali: le tre giovani imprenditrici hanno più volte raccontato di voler essere un modello per altre donne nelle STEM, partecipando a eventi con studenti per condividere la loro esperienza (“in molti ci dicevano che aero-spaziale sarebbe stato difficilissimo, invece eccoci qui” hanno dichiarato (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it)). Ecosmic infatti collabora con programmi di orientamento per ragazze nei licei e organizza webinar divulgativi sul tema dei detriti orbitale. Risultati: la startup ha vinto nel 2023 un grant dell’ESA per startup emergenti e ha già stretto contatti con operatori satellitari interessati al software. Socialmente, inoltre, affronta un tema di sostenibilità spaziale, contribuendo al movimento per uno spazio responsabile (un tema che l’ASI ha portato anche nelle scuole tramite una recente Call IAC 2024 sulla sostenibilità orbitale (ASI | Agenzia Spaziale Italiana)).
Tra le startup spaziali italiane nate da idee di giovanissimi c’è anche Involve Space, fondata nel 2021 in provincia di Como da un team con età media molto bassa. Il CEO, Claudio Piazzai, aveva soli 22 anni all’avvio e ha sfruttato un canale Instagram divulgativo per connettersi con altri appassionati e co-fondatori (Involve Space la startup che rivoluziona il settore aerospaziale). L’azienda sviluppa speciali palloni stratosferici a controllo attivo, con lo scopo dichiarato di “avvicinare chiunque allo Spazio, garantendo a tutti le stesse possibilità” (Involve Space la startup che rivoluziona il settore aerospaziale). In pratica Involve Space costruisce piattaforme a pallone capaci di raggiungere quote di decine di km e stazionarvi a lungo, come near-space satellites. La tecnologia combina due palloni (uno ad elio per salire, uno d’aria per scendere) e un sistema a compressore alimentato da pannelli solari che regola la galleggiabilità, il tutto governato da intelligenza artificiale (Involve Space la startup che rivoluziona il settore aerospaziale). Questo consente di svolgere missioni di monitoraggio in tempo reale della Terra (emergenze, infrastrutture) a costi e impatto ambientale ridotti (Involve Space la startup che rivoluziona il settore aerospaziale). Partners e supporto: la startup è cresciuta grazie all’incubatore Spazio Attivo Lazio Innova (collegato alla Regione Lazio), dove ha sede operativa (Involve Space la startup che rivoluziona il settore aerospaziale), e ha vinto premi a manifestazioni come Maker Faire Rome. Interessante la genesi “social” del team: l’uso dei social network non solo per comunicare i risultati, ma per trovare talenti e collaboratori tra altri giovani appassionati. Oggi conta 14 membri e collabora con università per sviluppare le componenti AI e sensoristiche. Risultati e impatto: oltre al progresso tecnico (i palloni hanno già effettuato test stratosferici con successo), Involve Space è attiva sul fronte educativo: organizza sessioni live durante i lanci, dove scuole collegate possono seguire la missione, e prepara un kit didattico per permettere alle classi di inviare piccoli esperimenti sui suoi palloni. Questa combinazione di business e educational outreach la rende un modello virtuoso di come una startup possa anche restituire valore formativo alla comunità.
Va sottolineato che molte di queste startup nascono come spin-off accademici o comunque con forte legame a progetti educativi. Leaf Space, ad esempio, fu fondata nel 2014 da neolaureati del Politecnico di Milano che avevano collaborato in un team studentesco di nanosatelliti: oggi è un’azienda affermata nei servizi di comunicazione satellitare con una rete globale di antenne (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia), ma mantiene rapporti con il PoliMi per offrire stage e laboratori. Analogamente AIKO (Torino, fondata nel 2017 da un dottorando poco più che ventenne) sviluppa intelligenza artificiale per l’automazione dei satelliti e ha assunto diversi ex studenti conosciuti tramite progetti universitari (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia). Questa filiera dimostra che iniziative come quelle descritte nella sezione precedente (team studenteschi, Fly Your Satellite!, ecc.) possono sfociare in vere attività imprenditoriali: alcune idee prototipate in ambito accademico vengono maturate dai giovani e lanciate sul mercato con il supporto di incubatori e investitori.
In campo internazionale, l’ispirazione imprenditoriale arriva anche da progetti come SpaceIL in Israele: tre ingegneri poco più che trentenni avviarono con pochi mezzi la costruzione di un lander lunare (progetto Beresheet), che pur non completando la missione in modo perfetto, riuscì ad allunare nel 2019. SpaceIL sin dall’inizio operò come organizzazione senza scopo di lucro con una forte missione educativa nazionale, incontrando oltre un milione di studenti nelle scuole israeliane durante lo sviluppo della sonda e dimostrando che “anche un piccolo paese può fare grandi cose nello spazio”. Questo ha generato in Israele un’ondata di entusiasmo STEM e diverse startup fondate da giovani che si sono sentiti parte della “Generazione Luna”. Anche se il contesto italiano è diverso, importare quello spirito – fare di ogni missione spaziale un motore per nuove vocazioni scientifiche e start-up – è sicuramente possibile.
Altri esempi globali: negli USA programmi come il NASA Space Apps Challenge (hackathon annuale sulle applicazioni spaziali) hanno visto studenti liceali vincere competizioni con prototipi poi sviluppati in startup. In India, l’organizzazione Space Kidz (già citata per KalamSat) continua a lanciare satelliti educativi: nel 2021 ha coordinato il lancio di Satish Dhawan SAT, un CubeSat realizzato da studenti con esperimenti biologici e anche una copia digitale del Bhagavad Gita – un mix di scienza e cultura – mostrando come idee di giovanissimi possano trovare spazio su lanci commerciali (in quel caso con ISRO, l’agenzia indiana).
Partner e network di supporto: per favorire queste esperienze, in Italia stanno emergendo incubatori ed eventi dedicati al settore spaziale giovanile. L’ESA Business Incubation Centre (BIC) di Lazio e Piemonte offre mentorship e fondi seed a startup spaziali (Ecosmic ne è un esempio concreto). Inoltre, manifestazioni come la New Space Economy ExpoForum e premi come “MirabilIS” coinvolgono spesso startup di studenti, dando visibilità e collegamenti con investitori. Anche l’ASI ha lanciato iniziative come Aerospace Job Talks e programmi di innovazione aperti ai giovani (ASI | Agenzia Spaziale Italiana), per fare scouting di idee fresche nelle università e persino nelle scuole: di recente, un concorso ASI-MIUR ha chiesto a classi di liceo di proporre idee imprenditoriali per riutilizzare dati spaziali, premiando le più innovative.
Impatto e risultati attesi: le startup giovanili spaziali generano un duplice valore. Da un lato impatti economici e tecnologici – nuovi brevetti, posti di lavoro altamente qualificati, prodotti o servizi utili (dai droni lunari ai palloni stratosferici). Dall’altro lato, un impatto sociale ed educativo: i giovani imprenditori diventano ambasciatori presso le nuove generazioni, testimoniando che in Italia si può fare innovazione e che lo spazio non è un settore “chiuso”. Molti di loro partecipano attivamente a eventi nelle scuole, fiere della scienza, mentorship in hackathon studenteschi, creando un effetto moltiplicatore. In questo modo, il concetto di team intergenerazionale assume più significati: non solo dentro la singola startup (dove magari c’è il professore emerito nel comitato scientifico accanto al CEO venticinquenne), ma anche come comunità dove ogni “generazione spaziale” ispira e aiuta la successiva. Così, l’ecosistema si autoalimenta: le prime startup di successo stimolano investimenti e curiosità, nascono programmi dedicati (corsi di imprenditorialità spaziale al PoliMi e PoliTo, ad esempio, sono già realtà (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia)), e sempre più studenti ambiziosi vedono nello spazio non solo un sogno lontano, ma un possibile percorso di carriera concreto – da intraprendere magari fondando la propria impresa.
Verso un’educazione spaziale creativa e imprenditoriale: il ruolo di Galaxy Bakery
Abbiamo esplorato missioni educative spaziali, laboratori che mescolano arte e scienza, e startup nate da menti giovani. Come collegare ora tutti questi elementi in un’unica visione? Galaxy Bakery si propone proprio come questo ponte: un “laboratorio educativo interplanetario” dove creatività e imprenditorialità si impastano assieme, fondato dalla giovane innovatrice Blu. Immaginiamo Galaxy Bakery come un luogo (fisico o virtuale) in cui studenti di diverse età “sfornano” idee spaziali, combinando le conoscenze apprese nei progetti descritti sin qui. Il nome evoca una “panetteria galattica”: un ambiente informale, giocoso, dove però si realizzano ricette innovative con ingredienti STEM, artistici e business.
Obiettivi educativi e interdisciplinari: Galaxy Bakery potrebbe, ad esempio, lanciare sfide mensili in cui una classe elementare crea storie illustrate di pianeti immaginari (arte), una classe media progetta esperimenti da inviarvi (scienza e tecnologia) e un gruppo di liceali elabora un piano per “commercializzare” il concept sotto forma di mostra o prodotto multimediale (imprenditorialità). Questo rispecchia esattamente lo spirito interdisciplinare emerso dai case study: coinvolgere bambini, adolescenti e adulti in un progetto comune dove ognuno apporta la propria prospettiva. Tali attività potrebbero ispirarsi ai format di Moon Camp (progettazione creativa), alle metodologie dei laboratori Golinelli (unire arte e realtà virtuale) e all’approccio learn startup visto nei giovani imprenditori (prototipazione rapida di idee, presentazioni in pubblico). Un obiettivo chiave sarebbe anche l’inclusione: in un “bakery” spaziale c’è spazio per tutti i talenti – dall’aspirante ingegnere che costruisce un mini-razzo in cartone, all’aspirante chef che inventa un menu per astronauti, al piccolo imprenditore che studia come vendere biscotti “stellari” per finanziare una gita al planetario.
Partner e rete: Galaxy Bakery potrebbe collegarsi con molte delle realtà citate. Potrebbe collaborare con scuole (portando format nuovi nei PCTO o nei doposcuola creativi), con agenzie spaziali come ASI/ESA (che potrebbero fornire esperti per mentorship o piccoli grant per i progetti migliori), con aziende e incubatori (immaginiamo un acceleratore che offra ai team di studenti supporto per trasformare un’idea di Galaxy Bakery in una vera startup studentesca). Anche enti culturali – musei scientifici, fab lab, biblioteche – potrebbero ospitare le attività itineranti di Galaxy Bakery, creando una comunità diffusa. In pratica, Galaxy Bakery agirebbe da hub connettore: mette in rete scuole, professionisti e risorse, così che un progetto nato in classe possa crescere con supporto esterno e magari culminare in un evento pubblico (una fiera, un contest).
Modalità di partecipazione e ruolo degli studenti: seguendo il modello dei challenge based learning, gli studenti in Galaxy Bakery sarebbero suddivisi in team con ruoli differenti, incoraggiando la collaborazione intergenerazionale. Si potrebbe avere il “maestro fornaio” (un mentor esperto, magari un universitario o un professionista in pensione) che guida il team, ma lascia ai “giovani panettieri” (gli studenti) il compito di misurare gli ingredienti e infornare – metaforicamente, di fare i calcoli, disegnare, programmare, sperimentare. Importantissimo sarebbe documentare tutto: blog, video, social media gestiti dagli stessi ragazzi per raccontare il processo, condividendo successi e fallimenti (in stile open innovation). In questo modo Galaxy Bakery diventerebbe anche una piattaforma di storytelling educativo, capace di ispirare altre scuole a replicare o adattare le sue “ricette”.
Tecnologie e strumenti: molto in linea con i progetti visti – stampa 3D (per creare prototipi di invenzioni spaziali), realtà virtuale/aumentata (per visualizzare gli ambienti extraterrestri creati dai ragazzi), elettronica open-source tipo Arduino/Raspberry (per piccoli esperimenti da lanciare con palloni stile Involve Space), e anche strumenti artistici tradizionali (dalla pittura alla musica) per assicurare che ogni idea venga espressa nel modo più ricco possibile. Anche il semplice forno di una cucina potrebbe diventare strumento didattico se pensiamo, ad esempio, a cuocere meteore fatte di impasti differenti per capire le differenze geologiche! Insomma, l’unico limite sarebbe la fantasia – esattamente quello che un laboratorio come Galaxy Bakery mira ad espandere.
Risultati attesi: nel breve termine, un aumento dell’entusiasmo e della partecipazione degli studenti alle materie STEM/STEAM, specie di quelli che nei percorsi tradizionali faticano a trovare motivazione. Nel medio termine, Galaxy Bakery potrebbe sfornare veri prototipi imprenditoriali: start-up simulate gestite da studenti, piccole imprese scolastiche che vendono gadget scientifici o organizzano eventi a tema spaziale per la comunità locale, creando anche impatto sociale (fundraising per scopi benefici legati allo spazio, come inviare un esperimento ideato da un piccolo comune sulla ISS in collaborazione con programmi internazionali). In prospettiva, iniziative del genere possono alimentare la workforce del settore spaziale italiano, facendo emergere precocemente talenti che poi proseguiranno in studi avanzati e carriere nel campo.
In conclusione, collegare le scuole al mondo dello spazio – dai satelliti costruiti in classe, all’arte che vola sulla ISS, alle startup under-30 – non è più fantascienza ma una realtà in espansione, sia in Italia che nel mondo. Progetti come Galaxy Bakery incarnano questa visione: trasformare la curiosità per le stelle in un percorso educativo concreto, dove un bambino di oggi possa crescere attraverso le fasi (studente, innovatore, imprenditore) restando sempre coinvolto e ispirato. Investire in queste iniziative interdisciplinari significa investire in una generazione creativa, competente e pronta a portare l’Italia verso nuove frontiere – che si tratti di lanciare un CubeSat o di aprire la prima “panetteria” su Marte. Le ricette ci sono già, testate dai case study analizzati; non resta che metterci all’opera e… buon appetito spaziale!
Fonti:
-
Progetti educativi ASI/ESERO e iniziative per scuole: ASI (2024). Portare lo spazio nelle scuole italiane (ASI | Agenzia Spaziale Italiana) (ASI | Agenzia Spaziale Italiana) (ASI | Agenzia Spaziale Italiana); ASI (2023). Programma Rosita robotica in aula (ASI | Agenzia Spaziale Italiana).
-
Programma EduSAT e reti di scuole: L’Eco di Bergamo (2011). Gli studenti vanno in orbita ( Gli studenti vanno in orbita con l’Agenzia aerospaziale – Cronaca) ( Gli studenti vanno in orbita con l’Agenzia aerospaziale – Cronaca); GAUSS Team (2011). EduSAT mission (EDUSAT) (EDUSAT).
-
Esempi di missioni studentesche italiane: Politecnico di Torino (2025). Team CubeSat – Fly Your Satellite! (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino) (Il Team CubeSat progetterà una missione satellitare con l’ESA | Politecnico di Torino); Notizia Oggi (2021). Liceo Gattinara progetta un satellite (Liceo Gattinara al lavoro per progettare un satellite) (Liceo Gattinara al lavoro per progettare un satellite).
-
Competizioni ESA per scuole: ASI/ESERO (2024-25). Bando Moon Camp, Mission X, Climate Detectives, CanSat, AstroPi (ASI | Agenzia Spaziale Italiana) (ASI | Agenzia Spaziale Italiana).
-
Caso globale Cubes in Space – KalamSat: World Economic Forum (2017). Indian teen builds world’s lightest satellite (Indian teen builds world’s ‘lightest satellite’ | World Economic Forum) (Indian teen builds world’s ‘lightest satellite’ | World Economic Forum).
-
Laboratori STEAM in Italia: Fondazione Golinelli (2023). Oltre lo spazio, oltre il tempo – mostra e gemello digitale (Fondazione Golinelli) (Fondazione Golinelli).
-
Arte e spazio nel mondo: NextNature (2022). Moon Gallery, museo sulla Luna (The Moon Gallery: the first museum in space) (The Moon Gallery: the first museum in space); ArtMoonMars (2020) – Programma Arte-Luna-Marte ([
ArtMoonMars · EuroMoonMarsArtMoonMars · EuroMoonMars -
Startup spaziali giovani in Italia: Wired Italia (2023). Startup italiane pronte a conquistare lo spazio (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia) (Spazio, le startup italiane pronte a conquistarlo | Wired Italia); Corriere della Sera (2024). Tre giovani italiane e i detriti spaziali (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it) (Detriti spaziali, l’idea vincente di tre giovani italiane per proteggere i satelliti dalle collisioni | Corriere.it); Maker Faire Rome (2024). Involve Space palloni stratosferici (Involve Space la startup che rivoluziona il settore aerospaziale) (Involve Space la startup che rivoluziona il settore aerospaziale).